 Dopo
il regno dell’avido e infido Enrico VII Tudor, fu per molti un benvenuto
sollievo averne come successore il simpatico ed atletico Enrico VIII.
Era un uomo che amava la musica, le arti militari ed era interessato a
far sì che l’Inghilterra avesse la sua flotta. Era considerato
dai suoi contemporanei un autentico principe del Rinascimento.
Dopo
il regno dell’avido e infido Enrico VII Tudor, fu per molti un benvenuto
sollievo averne come successore il simpatico ed atletico Enrico VIII.
Era un uomo che amava la musica, le arti militari ed era interessato a
far sì che l’Inghilterra avesse la sua flotta. Era considerato
dai suoi contemporanei un autentico principe del Rinascimento.
Enrico, però, si comprovò essere altrettanto privo di scrupoli che suo padre, un uomo che non tollerava alcuna opposizione, reale od immaginaria. Cominciò subito la sua prassi di “sterminio dinastico” facendo eliminare il Duca di Buckingam, la Contessa di Salisbury (sorella del Conte di Warwick) e, nel 1546, il poeta Henry Howard, Conte del Surrey, nipote del Buckingham.
Per comprendere la marea di esecuzioni e l’eliminazione persino di coloro che avrebbero potuto avere il minimo diritto al trono, dobbiamo rammentarci della sterilità dei Tudor, una maledizione che li perseguitava. Tutti i figli maschi nati a Caterina d'Aragona, sua moglie, ed Enrico erano morti. Enrico non aveva altro proprio erede se non la Principessa Maria; era impensabile, a quel tempo, che una donna dovesse governare l’Inghilterra.
Quando Enrico sposò la vedova di suo fratello, la soluzione sembrava abbastanza semplice: avrebbe ottenuto l’annullamento del suo matrimonio ed avrebbe sposato la giovane, attraente, disponibile e si sperava fertile Anna Bolena [Anne Boleyn]. Il Re, però, non considerava l’ostinazione di Carlo V, il più potente monarca d’Europa, nipote di Caterina e, cosa più importante di tutte, colui che virtualmente controllava il Papa. Enrico, però, si dimostrò altrettanto ostinato, e coloro che non avevano appoggiato i suoi sforzi di vedersi annullare il matrimonio, avrebbero ben presto dovuto sentire la sua ira.
Il Cardinale Pole, figlio della Contessa di Salisbury, si sarebbe posto a capo dell’opposizione al Re, così la sua famiglia fu destinata all’eliminazione. Pole si era già recato nel 1529 a Parigi, per cercare un’opinione favorevole nella questione del divorzio. Più tardi egli si sarebbe posto dalla parte di Carlo V contro il Re, diventando famoso proprio per il suo animato attacco al monarca inglese. Apparirà poi come legato al Concilio di Trento e non avrà più una parte significativa negli affari inglesi se non dopo la salita al trono di Maria. Nel frattempo, il figlio di un macellaio di Ipswich avrebbe iniziato la sua rapida ascesa ad una delle cariche più alte del Paese.
Thomas Wolsey fu associato al Consiglio della Corona nel 1509, il primo anno del lungo regno di Enrico. Mentre il Re si occupava di altre faccende, egli lasciò gran parte dell’amministrazione alle abili mani del Wolsey, diventando Lord Cancelliere nel 1515. L’ambizioso Wolsey poi assunse altre cariche in rapida successione, inclusa quella dell’Arcivescovo di York, Legato papale e cardinalizio che, nelle parole di un ambasciatore veneziano, “governava il regno”. Era negli stessi interessi di Enrico dare mano libera al suo primo ministro, ma solo fino ad un certo punto.
Wolsey, come molti altri nel regno, si pregiudicò del tutto la carriera per aver fallito nell'ottenere il divorzio di Enrico da Caterina d’Aragona. Era l’imperatore Carlo V ad essere il maggiore ostacolo, perché egli aveva da poco sconfitto il suo principale rivale europeo, Francesco I, e fatto prigioniero Papa Clemente VII. Carlo V era più interessato a ciò che avveniva in Italia di ciò che succedeva a sua zia, ma Enrico aveva ricevuto il titolo di “Difensore della Fede” da Papa Clemente per i suoi sforzi di mantenere sotto scacco le forze del Protestantesimo in Inghilterra, Carlo non era il solo che ovviamente sentisse di dover essere all’altezza del suo titolo, comunque guadagnato.
Enrico VIII fa perseguitare i luterani del proprio regno mettendoli a morte per eresia o costringendoli all'esilio. Nel 1521 difende il papato contro Lutero scrivendo una monografia in latino, l'”Assertio septem sacramentorum contra Martinum Lutherum”. E' per questo che riceve da Papa Leone X il titolo di Defensor fidei.
Nella sua passione per la bella Anna e per il suo desiderio d'un erede maschio, Enrico aveva reso chiaro a tutti di volere un divorzio veloce. A causa del fallimento del Wolsey nel tentativo di risolvere la questione, egli fu bandito da corte e chiamato a comparire di fronte ad un tribunale con l'accusa di tradimento. Morì mentre si recava ad affrontare il re. Tutto ciò che aveva acquisito quanto a ricchezza e potere sarebbe sfumato nel nulla, e tutto per non avere onorato gli interessi del re. In ogni caso, Wolseley aveva grandemente aumentato il lavoro della Corte di Giustizia del Lord Cancelliere [Court of Chancery] e della Camera Stellata, Corte deputata a tenere a freno la nobiltà. In ben due occasioni aveva cercato di essere eletto Papa, ma il dilemma sul divorzio del re si sarebbe comprovato essere troppo per lui.
Camera stellata. Tribunale reale inglese istituito nel 1487; prese nome (Star Chamber) dalla decorazione del locale del palazzo reale di Westminster dove si riuniva per decidere di questioni di natura sostanzialmente politica, sottratte alla magistratura ordinaria per sorvegliare gli sceriffi, reprimere le rivolte e in particolare giudicare i casi a sfondo politico che il governo riteneva opportuno sottrarre alla giurisdizione delle magistrature ordinarie. Forte strumento di repressione politica, fu abolita nel 1641.
Fu così scartato quando il re non lo ritenne più utile. Il suo licenziamento e le accuse contro di lui sono pure un chiaro segnale del declino dell'influenza della Sede pontificia nella politica internazionale. La crescita di nazioni-stato indipendenti da Roma, sarebbe stato un tema ricorrente in Europa per i prossimi secoli.
Forse il distacco dell'Inghilterra dal papato era comunque inevitabile. La Chiesa medievale era moribonda, fossilizzata, non più all'altezza dei vasti cambiamenti che stavano avvenendo in economia, nella politica e nelle condizioni sociali. Vi era già stato un sentore di quanto sarebbe accaduto quando John Wycliffe, durante il regno di Edoardo III, aveva predicato l'idea rivoluzionaria che la grazia procedesse dalla lettura della Bibbia e non dai benefici della Chiesa e del clero.
Famosa è la Bibbia in inglese di John Wycliff (ed. del 1380). Wycliff (o Wycliffe), era un teologo di Oxford che tradusse il latino della Vulgata, poichè il Greco del NT e I’ebraico dell’AT erano a lui inaccessibili (Wycliff inventò tra l’altro anche le lenti bifocali, inoltre spese molti anni della propria vita scrivendo ed insegnando contro i dogmi della chiesa cattolica romana; 44 anni dopo la sua morte il Concilio di Costanza ordinò che le sue ossa fossero disseppellite bruciate e sparse sull’acqua!).
I dissenzienti, conosciuti come i Lollardi, stavano aumentando i loro attacchi contro gli abusi dei vescovi, e William Tyndale era impegnato a tradurre il Nuovo Testamento in inglese. Ora, con Enrico in disaccordo con il Papa, imprigionato e demoralizzato, e la Chiesa cattolica allo sbando, con gli insegnamenti di Martin Lutero che si stavano diffondendo in ogni angolo d'Europa, le cateratte della Riforma si sarebbero aperte e nessuno sarebbe più stato in grado di richiuderle.
Enrico ottenne il suo divorzio nonostante l'opposizione di Carlo V e del Papa. Egli semplicemente usò l'autorità dello stato e del cosiddetto Parlamento per la Riforma [Reformation Parliament] che, convocato per la prima volta nel 1529, per i prossimi sette anni avrebbe efficacemente distrutto in Inghilterra la Chiesa medievale.
Parlamento per la Riforma. Questa definizione era stata data al Parlamento inglese negli anni dal 1529 al 1536. Nella sua prima sessione (nov./dic. 1529), il Parlamento chiese ad Enrico VIII di prendere misure contro il Cardinale Wolsey. Susseguentemente il Parlamento promulgò degli atti per definire la natura della frattura con Roma e la fondazione della Chiesa d'Inghilterra. Nel 1532 (un anno dopo che Enrico fu riconosciuto come Capo supremo della Chiesa d'Inghilterra), i comuni si opposero apertamente all'autorità dei tribunali ecclesiastici e affermarono che nessuna legge ecclesiastica potesse essere promulgata senza l'autorità del re, Un anno più tardi, nel Restraint of Appeals (Atto di limitazione degli appelli), essi codificano l'indipendenza legale del regno d'Inghilterra da Roma. Quando la “grande questione” di Enrico divenne problematica (il suo matrimonio con Caterina d'Aragona, vedova di suo fratello), il Parlamento continuò ad appoggiare il loro re contro il Papa di Roma
Nel 1533
Enrico sposò la già incinta Anna Bolena e, dopo la morte
dell'Arcivescovo di Canterbury, nominò Thomas
Cranmer ad eseguire i suoi ordini in quella funzione.
La rottura ufficiale con Roma avvenne nell'aprile del 1533 con l'approvazione
dell'Atto di Limitazione degli Appelli [Act of Restraint of Appeals] che
decretava:”Questo regno di Inghilterra è un impero”.
In questo testo si rileva la forte influenza di Thomas Cromwell [vedi altra nota], che può considerarsi un'affermazione concisa di principi presi dalle opere di Marsiglio da Padova. Marsiglio da Padova (1275-1342), filosofo politico, è spesso considerato uno dei precursori del pensiero politico della Riforma. Il suo libro: Defensor Pacis afferma che l'elemento unificante della società è lo stato, non la Chiesa, e toglie al papato la giurisdizione politica, definendo il potere della Chiesa solo spirituale. Ripubblicato nel 1517, fu posto all'indice nel 1559 e fu studiato attentamente da molti Riformatori. Queste idee sono poi riprese da Erasto. L'erastianismo è la dottrina che afferma come lo stato abbia diritto di intervenire e governare sulle questioni ecclesiastiche. Tommaso Erasto nasce nel 1524 in Svizzera. Studia teologia a Basilea e poi medicina e filosofia a Padova e Bologna. La Chiesa d'Inghilterra è talvolta definita come erastiana nel fatto che i vescovi sono incaricati dalla Corona ed i maggiori cambiamenti liturgici devono avere l'approvazione del Parlamento.
Un anno più tardi, l'Arcivescovo Cranmer dichiarava che il matrimonio del Re con Caterina d'Aragona era nullo [null and void]. Anna Bolena fu debitamente incoronata regina e diede alla luce, tre mesi dopo, ad Elisabetta. Il Papa, a sua volta, debitamente scomunicò sia Cranmer che Enrico.
Anna Bolena. Regina d'Inghilterra (1507-1536). Anne Boleyn, o Bullen, figlia di sir Thomas, che in seguito divenne conte di Wilthshire e Ormonde, nacque intorno al 1507 (ma alcuni storici ritengono che possa essere nata alcuni anni prima, intorno al 1502), e nel 1519 seguì suo padre in Francia, dove entrò al servizio reale come damigella. Tornata in Inghilterra nel 1522 frequentò la corte, e venne notata non tanto per la sua bellezza - era di media statura, di carnagione scura, naso lungo e bocca larga, caratteri che affiorano molto bene nel disegno di Holbein - quanto per la sua civetteria e i bellissimi occhi scuri. Fra i suoi corteggiatori ci fu il poeta sir Thomas Wyat, e Henry Percy, erede del conte di Northumberland, che avrebbe dovuto sposarla, mentre il cardinale Wolsey progettava un matrimonio con il conte di Ormonde. Non si sa con precisione quando iniziò la relazione con Enrico VIII, poiché le lettere che essi si scambiarono non sono datate; ma è probabile che iniziò intorno al 1525, poiché già nel 1527 il re dichiarò di voler divorziare da Caterina, giustificando la sua richiesta con il fatto che la moglie, ormai ammalata, non aveva avuto figli maschi e che il matrimonio non era valido, in quanto Caterina era vedova di suo fratello. Anna, però, gli dà una figlia femmina. La delusione del re, che desiderava un figlio maschio, fu grande, e i rapporti con la moglie peggiorarono rapidamente; la regina aveva modi arroganti anche nei confronti di Caterina e di sua figlia Mary, e questo le procurò molti nemici. Il re, perso interesse per Anna, si diede ad altri amori; intanto nel 1534 Anna aveva avuto un aborto, e il 29 gennaio 1536, lo stesso giorno dei funerali di Caterina, diede alla luce un figlio maschio morto. Il 2 maggio dello stesso anno Anna venne rinchiusa nella Torre di Londra accusata di adulterio con vari uomini, fra cui il fratello lord Rochford. Il 12 maggio vennero riconosciuti colpevoli sir Francis Weston, Henry Norris, William Brereton e Mark Smeaton. I1 15 maggio una giuria composta di 26 pari del regno, fra cui il padre stesso di Anna, e presieduta da suo zio, il duca di Norfolk, condannò a morte all'unanimità sia Anna che il fratello; il 17 maggio vennero giustiziati i presunti amanti, e il 19 Anna venne decapitata. La regina non ammise mai le proprie colpe, che per noi restano non documentate; tuttavia non è facilmente credibile che un regolare tribunale abbia potuto emettere una sentenza di tale gravità senza possedere qualche prova evidente di colpevolezza, tanto più che nel tribunale erano presenti sia il padre che lo zio dell'accusata.
Dopo il 1534 gli avvenimenti si mossero ancora più rapidamente. L'Atto di Supremazia di quell'anno dichiarava che il re era il Capo supremo della Chiesa di Inghilterra ed il Papa designato ufficialmente come Vescovo di Roma.
La Chiesa di Inghilterra enriciana non va però pensata come una sorta di chiesa ginevrina, certamente la Bibbia è considerata l'autorità suprema in materia di fede, insieme ai “Tre Simboli” (Apostolico, di Nicea, e di Atanasio), ma permangono in essa elementi cattolici evidentissimi: vengono conservati i sacramenti del battesimo degli infanti, la penitenza, l'eucarestia (dogma della transustanziazione), calendario liturgico e immagini (che però non potevano essere adorate), invocazioni ai santi, purgatorio, preghiere per i defunti (ma non le indulgenze), paramenti ecclesiatici, successione episcopale; inoltre Cranmer, riuscì a mantenere il re lontano dal papa avvicinandolo al luteranesimo solo appoggiando la sua politica matrimoniale (non diversamente da Lutero che aveva appoggiato la bigamia di Filippo d'Assia, giustificando ciò come un problema pratico e temporale). In seguito il re prese a difendere con forza la dottrina dei sette sacramenti cattolici (Bishop's Book). Risale a quest'epoca la decisione del re di collocare in ogni chiesa inglese una bibbia.
Non vi furono in Inghilterra sollevazioni dei cattolici. Enrico continuava a considerarsi un devoto cattolico, conservando il suo titolo di “Difensore della Fede” ed, ovviamente, essendo fiero d'un tale appellativo. Non vi furono fratture con Roma su questioni dogmatiche. Il re stesso non aveva un grande desiderio per una separazione completa, ma le cose maturarono con la salita al potere Thomas Cromwell, considerato da molti l'architetto della Riforma inglese.
Thomas Cromwell (1489–1540). Passa gran parte della prima parte della sua vita in Europa come soldato, contabile e mercante, ma ritorna in Inghilterra nel 1512 circa, dove entra nel commercio della lana e presto diventa avvocato. Nel 1520 la sua carriera fa un salto di qualità. Diventa segretario legale del Cardinale Wolsey, al servizio di Enrico VIII. Wolsey rende Cromwell responsabile della dissoluzione dei monasteri più piccoli. Quando Wolsey perde il favore del re, Cromwell è sicuro. Nel 1523 entra a far parte del Parlamento. Conquista la fiducia del re e sale velocemente di grado. Nel 1532 è capo ministro del re. I suoi doveri includono la redazione degli atti del Parlamento al tempo della Riforma. Cromwell crede fermamente nella teoria di uno stato nazionale sovrano e questo è riflesso nella sua politica. Considerato come originatore dell'idea del re come capo supremo della chiesa, nel 1534 l'assicura. Mel 1535 Cromwell viene eletto Vicario Generale e così diventa praticamente l'unico a controllare la Chiesa d'Inghilterra. Negli anni seguenti vede i suoi titoli cambiare rapidamente, fino a diventare conte dell'Essex nel 1540. La politica religiosa del Cromwell dimostra la sua simpatia per le idee luterane. Suscita sempre di più l'opposizione dei suoi avversari filo-cattolici, soprattutto per le sue simpatie protestanti. Cade, così, in disgrazia in quello stesso anno ed è fatto decapitare per tradimento ed eresia dalle accuse dei suoi avversari, che considerano i suoi contatti con i principi luterani tedeschi un attentato alla nazione inglese.
La
dissoluzione dei monasteri (1536-40). Cromwell eseguiva in modo
più che zelante la volontà di Enrico, ma si può dire
con sicurezza che pure mettesse in atto molte delle sue idee. Sebbene
Sir Thomas Moore, uomo inizialmente molto apprezzato dal re, ed il vescovo
Fisher fossero stati condannati a morte per essersi rifiutati di riconoscer
le pretese di Enrico sulla Chiesa di Inghilterra, pure 22 altri inglesi
furono bruciati sul rogo per essersi rifiutati di accettare il Cattolicesimo.
Poi, quando si cominciò a temere un'attesa invasione dalla Francia,
la dissoluzione dei monasteri in Gran Bretagna procedette a rapido passo,
perché divennero un facile obiettivo per soddisfare il bisogno
di Enrico di disporre di grandi quantità di denaro per difendere
le coste e per rafforzare la flotta. Wolsey stesso aveva iniziata la cosa,
soprattutto per poter avere disponibilità di denaro per fondare
Corti di giustizia [Chanceries] e scuole, ma l'opera fu portata avanti
volentieri da Cromwell, che così avrebbe potuto disporre di ingenti
risorse.
Le pittoresche rovine ecclesiastiche che si possono ancora vedere tutt'attraverso
l'Inghilterra, possono dare solo una piccola idea della grandezza e della
ricchezza di questi monasteri. Forse avevano posseduto quasi un quarto
della terra arabile della nazione, e la quantità di gioielli, vasellame
prezioso, reliquie e artefatti d'oro che possedevano, doveva essere stata
davvero enorme, per non parlare delle loro vaste greggi ed enormi fasce
del migliore terreno agricolo del paese. Enrico era determinato ad impossessarsene
per intero, così tutti i monasteri furono distrutti e la loro terra
presa in carico dalla Corona. In tre anni, due atti di dissoluzione portarono
alla fine ogni influenza monastica nell'isola britannica. Una debole protesta
di Cattolici nel nord, conosciuta come il Pellegrinaggio della Grazia,
fu soppressa facilmente.
Poi una violenta ondata iconoclasta spazzò pure il paese. Nel 1538, l'anno stesso in cui fu dissolto l'ultimo monastero, il primo ministro di Enrico, ed architetto della Riforma in Inghilterra, emanò ingiunzioni a che ogni chiesa parrocchiale avesse una Bibbia in inglese e che tutte le immagini religiose e santuari fossero distrutti. Thomas Cromwell si rallegrava che finalmente l'Inghilterra fosse stata sottratta al potere del Papa e che il re soltanto fosse diventato l'arbitro degli affari religiosi. Fu però distrutto il prezioso retaggio di un'antica nazione. Il valore di tante opere d'arte, libri ed architettura, era nullo per coloro che eseguivano i decreti di Cromwell. La distruzione dei santuari incluse pure il sacrario di Thomas Beckett, forse il luogo santo più popolare dell'Inghilterra, meta di numerosi pellegrinaggi.
Oltre al re ed ai suoi nobili, pure molti altri erano felici nel vedere scomparire i monasteri e diminuire il potere della Chiesa. Gli abati vivevano come principi, le loro dimore erano molto più simili a palazzi nobiliari che a case religiose. La pietà religiosa era notevolmente assente dai loro magnifici edifici e vaste proprietà. La casa del vescovo a St. David rivaleggiava in grandezza con la stessa cattedrale. Non fu soltanto il grande erudito Erasmo da Rotterdam a condannare le oscene ricchezze delle grandi dimore dei religiosi inglesi. Egli scriveva nel 1504 nel suo Enchiridion che la vita monastica non doveva essere equiparata con la vita virtuosa e che i monasteri stessi fossero “un anacronismo antiquato, non più all'altezza dei tempi e non più amato, pronto a cadere”. Di fatto essa decadde. Le vaste proprietà dei monasteri furono così vendute a coloro che se le potevano permettere e fu così stabilita in Inghilterra una ricca aristocrazia terriera che avrebbe dominato la scena del paese per secoli.
La
situazione del Galles. Con la fine del monachesimo in Inghilterra,
pure la nazione gallese perse ogni speranza di riconquistare la sua indipendenza.
Un'espressione che descrive un gallese che faccia finta di aver dimenticato
la sua lingua o che affermi di aver perduto la propria identità
nazionale per far fortuna nella società inglese, o che voglia riscuotere
popolarità fra i suoi amici è “Dic-Sion-Dafydd”.
Il termine era sconosciuto nel Galles del 16° secolo ma, a causa della
dura legislazione penale imposta ai suoi abitanti dopo la rivolta di Owain
Glyndwr, divenne necessario per molti gallesi chiedere al Parlamento di
essere “fatti inglesi” per poter godere dei privilegi riservati
agli inglesi, incluso il diritto di comprare e di possedere terra, secondo
la legge inglese.
Tali richieste potevano sembrare odiose ai patrioti gallesi, ma per la
nobiltà rurale, ambiziosa e socialmente mobile, che sorgeva rapidamente
in Galles e nelle Marche, esse erano un passo necessario se volevano avere
una qualsiasi possibilità di avanzamento sociale. Nell'esercito,
naturalmente, i mercenari gallesi, che non combattevano più con
Glyndwr per un Galles indipendente, erano molto ricercati dopo Enrico
V per le sue campagne in Francia, e l'abilità degli arcieri gallesi
in battaglie come ad Agincourt, era leggendaria. Tali esempi di fedeltà
al loro comandante, il sovrano inglese, contribuì molto a far dimenticare
pensieri latenti di indipendenza e prepararono la via per la stupefacente
lealtà del Galles verso i Tudor.
Quando Enrico Tudor ascese al trono come Enrico VII, erano state già poste le basi per le grandi proprietà gallesi e molti degli affari quotidiani della nazione erano controllati da signorotti locali, molti fra i quali discendevano da famiglie inglesi e si sposavano con loro pari in Galles. La loro fedeltà era verso la Corona od il Parlamento, o per entrambi, ma non altrettanta verso il loro paese natio, tanto da associarla sempre di più ai sovrani Tudor. O i gallesi si rendevano conto di quanto disperata fosse la loro posizione, o i loro leader, in vero stile “Dic-Sion-Dafydd”, erano troppo indaffarati a godere i frutti della cooperazione con Londra. Ecco, così come l'anno 1536 non fu un grosso trauma per il Galles: tutti gli ingredienti per la sua accoglienza come parte integrante del regno, erano già presenti da tempo.
Il cosiddetto “Atto d'Unione” di quell'anno, insieme alla sua versione corretta del 1543, sembrava inevitabile. Più di uno storico ha rilevato che l'unione con l'Inghilterra era stata raggiunta, in realtà, già nello “Statuto di Rhuddlan” del 1284. La nuova legislazione fu ben accolta da molti in Galles, soprattutto dai proprietari terrieri, dagli interessi commerciali e dai riformatori religiosi, e perché no? Non dichiarava forse che “Le persone nate o che nasceranno in detto Principato... del Galles, avranno, godranno ed erediteranno tutte le singole libertà, diritti, privilegi e leggi ... allo stesso modo in cui hanno, ne godono, od ereditano gli altri sudditi del Re”.
Con questo Atto, “finalmente e per sempre”, il Principato del Galles fu incorporato nel Regno di Inghilterra. Gran parte di questa decisione fu di abolire ogni distinzione legale fra il popolo in ciascuna delle parti della nuova frontiera. Da allora in poi, la legge inglese sarebbe stata l'unica legge riconosciuta nei tribunali del Galles. Oltre a questo, per mettere l'amministrazione del Galles nelle mani della nobiltà locale gallese, era stato necessario creare una classe dominante gallese che padroneggiasse non solo l'inglese, ma che lo usasse in tutte le questioni civili e legali.
Così, inevitabilmente, la classe dirigente gallese sarebbe stata staccata dalla lingua del loro paese. Però, come rilevato prima, i loro occhi erano focalizzati su ciò che aveva da offrire Londra ed altre grandi città dell'Inghilterra, non sulle briciole che avrebbero potuto raccogliere in Galles. Il popolo gallese fu privato di un proprio governo, di una loro capitale, e persino di una città abbastanza grande per attrarre un'opportunista classe media urbana, e oberata da una lingua che “non assomiglia per nulla né è consonante alla lingua madre naturale usata in questo regno”. Una lingua che persistentemente rifiutava di morire.
L'insorgenza
delle classi media gallesi trovò un parallelo in Inghilterra, dove
i privilegi politici della vecchia nobiltà erano stati drasticamente
ridimensionati, e dove sorgeva rapidamente una nuova classe. Attraverso
i suoi ministri, Enrico continuava ad aumentare i poteri della Camera
Stellata a livello nazionale, e si accertava che i Giudici di Pace, reclutati
fra la nobiltà terriera, assicurassero che la volontà del
re fosse rispettata a livello locale. Gli intrighi che il re metteva in
atto all'estero avevano bisogno di finanziamenti che il re si assicurava
vendendo i possedimenti sottratti di recente ai monasteri. La nobiltà
rurale ne fu beneficiaria in più di una maniera, perché
le richieste insistenti di denaro che il re faceva loro, e la concessione
di privilegi che il re dava loro in cambio, conduceva solo ad un aumento
dei poteri del Parlamento a scapito della Corona. Nel 1554 comparve per
la prima volta il termine House of Lords (Camera dei Lord), indicazione
questa della rapida crescita dell'altra, la camera bassa, la Camera dei
Comuni che, da quel tempo in poi, fu sempre pronta a sfifare il potere
dei Lord.
La situazione della Scozia. Gran parte del bisogno che Enrico aveva di
denaro perveniva dalle sue guerre contro la Scozia durante gli anni 1542-46
e con l'alleato della Scozia, la Francia. Nel 1488 in Scozia, Giacomo
IV era salito al trono all'età di 15 anni, accompagnato dal suo
reggente, il conte Douglas. Gli amici del conte ed i cospiratori, ricevevano
ricche ricompense per i loro servizi. Uno di questi era Laird Hepburn
di Hailes, che divenne Conte di Bothwell e Lord Alto Ammiraglio.
 Giacomo
IV (di Scozia) aveva grandi ambizioni. Il suo paese godeva d'un enorme
prestigio, conservando in equilibrio il potere fra l'Inghilterra e la
Francia, sempre in guerra fra di loro. Egli credeva che la Scozia potesse
essere determinante nel liberare Costantinopoli dai Turchi. Per questo,
come prima mossa, egli fece costruire una grande flotta, inclusa una grande
nave da guerra The Great Michel. Egli così avviò l'industria
marittima scozzese che, più avanti nel tempo, divenne l'invidia
del mondo. Giacomo doveva, in primo luogo, stabilire pacifiche relazioni
con l'Inghilterra, il suo potente vicino meridionale.
Giacomo
IV (di Scozia) aveva grandi ambizioni. Il suo paese godeva d'un enorme
prestigio, conservando in equilibrio il potere fra l'Inghilterra e la
Francia, sempre in guerra fra di loro. Egli credeva che la Scozia potesse
essere determinante nel liberare Costantinopoli dai Turchi. Per questo,
come prima mossa, egli fece costruire una grande flotta, inclusa una grande
nave da guerra The Great Michel. Egli così avviò l'industria
marittima scozzese che, più avanti nel tempo, divenne l'invidia
del mondo. Giacomo doveva, in primo luogo, stabilire pacifiche relazioni
con l'Inghilterra, il suo potente vicino meridionale.
Nel 1501 Giacomo aveva 28 anni. Era tempo di prendere moglie. Scelse Margaret Tudor, figlia quattordicenne di Enrico VII, a cui fece seguito un accordo firmato fra i due monarchi, che prometteva un trattato di pace perpetua. Il Papa si impegnò a scomunicare chiunque infrangesse la parola data. La cerimonia ebbe luogo nel palazzo di Holyrood, ad Edimburgo, a cui parteciparono molti dignitari inglese. Tutto sembrava andare nel migliore dei modi.
Giacomo continuò ad usare il suo regno come elemento pacificatore fra Inghilterra e Francia. I suoi sforzi gli meritarono il titolo di “Rex Pacificator”. Quando il Papa, il Re di Spagna ed il Doge di Venezia formarono una “santa” lega contro la Francia, ad essa si associò Enrico VII di Inghilterra, il suocero del re di Scozia. Giacomo, però, non si associò alla lega. Era, infatti, convinto che la sopravvivenza della Francia fosse essenziale per la stabilità dell'Europa. Rinnovò, così, l'Alleanza Auld che era iniziata nel 1422 sotto la Reggenza di Albany. Quando la Francia fece appello alla Scozia perché le venisse in aiuto, come aveva fatto quando Buchan aveva risposto in modo così meraviglioso in tempi passati, Giacomo, con poca saggezza, mandò un ultimatum al re inglese.
La risposta di Enrico, benché tipica di un monarca inglese, sorprese non poco Giacomo e l'intera Scozia. Egli dichiarò sé stesso essere “il vero padrone della Scozia”, un regno governato dal re scozzese solo “per omaggio”. Questo era troppo da sopportare per un orgoglioso scozzese, e rispose marciando sull'Inghilterra a capo di un grande esercito, nel settembre del 1513, alla faccia di un trattato di pace che avrebbe dovuto “durare per sempre”. Il risultato fu Flodden, una delle battaglie più disastrose della storia scozzese.
Il figlio naturale di Giacomo, Alessandro, migliaia dei migliori e più brillanti giovani, molti fra i più coraggiosi e forti capi degli Highland, grandi leader ecclesiastici, e molti conti e lord, persero la vita nella tragica battaglia di Flodden. Sebbene nessuno sapesse ciò che avvenne al corpo di Giacomo, si sviluppò rapidamente in Scozia la leggenda che un giorno Giacomo non era morto, ma che sarebbe ritornato in Scozia, una leggenda simile a quella gallese sul ritorno di Arturo e Glyndwr. Sorse così un tipico mito celtico da ciò che il popolo vedeva come il rifiuto di un re gallese (Enrico VIII) di garantire una sepoltura onorevole per il corpo di un re scozzese (Giacomo IV).
Ora la Scozia
non aveva più né re né esercito. Dato che Giacomo
V era ancora un bambino, la regina Margaret assunse la reggenza. Nel 1514,
però, con una mossa che portò ad un sorprendente cambiamento
di fortune per un paese verso il quale mostrava poco amore, Margaret sposò
il Conte di Angus e la reggenza passò al Duca di Albany, educato
in Francia, nipote di Giacomo III. Albany (che era a capo del partito
nazionale, o francese, continuò nella sua alleanza con la Francia,
paese che era riuscito a districarsi dal precedente e grave pericolo dal
fallimento dei suoi nemici a formare un fronte unito. Dopo una serie di
complotti di Margaret e suo marito fallirono, la misera e sfortunata regina
fu costretta a fuggire in Inghilterra (la coppia aveva cercato di rapire
il giovane Giacomo V). Questo diede al fratello di Margaret, Enrico, una
scusa in più per continuare le sue interferenze negli affari scozzesi.
Nel 1524, Albany tornò in Francia.
In Scozia ritornò il caos. Una serie di battaglie fra i Douglas
e gli Hamilton, inclusa una combattuta nelle strade di Edimburgo, avevano
lasciato il potente clan del Douglas in controllo del giovane re e quindi
della Scozia. Giacomo, però, che aveva dichiarato d'essere pronto
ad essere re all'età di 14 anni, sfuggì a coloro che lo
avevano catturato e si rifugiò a Stirling. Giurò di vendicarsi
contro Angus Douglas, che riuscì a scacciare dalla Scozia per cercare
rifugio presso il re inglese. Giacomo V poteva così cominciare
a ristabilire l'ordine nella sua nazione sofferente. Cominciò saggiamente
dichiarando una tregua con l'Inghilterra.
Nel frattempo,
gli effetti della Riforma cominciarono ad avere seri e durevoli effetti
sulla Scozia. Nella lotta fra Protestantesimo e Cattolicesimo, iniziò
una folle gara in vista di un'alleanza matrimoniale con il re scozzese.
Tenendo sempre a mente l'Alleanza Auld, egli scelse Maddalena, figlia
del re francese Francesco I, e quando lei morì sei mesi dopo, egli
prese in moglie un'altra principessa francese, Maria de Guise-Lorraine.
Sfortunatamente per la storia scozzese, lei non gli diede alcun figlio
maschio.
Anche Enrico VIII d'Inghilterra aveva la stessa apparente sfortuna nel
non poter avere un erede maschio. Egli divenne sempre più aggressivo
nella sua politica verso la Scozia. Nel 1534 egli aveva rotto con Roma,
si stava preparando ad assorbire completamente il Galles ed aveva piani
per far rivolgere la Scozia contro la Francia, rendendola una nazione
protestante. Quando a Giacomo fu offerta la corona d'Irlanda nel 1542,
Enrico portò a Nord un esercito proclamandosi Lord Superiore della
Scozia. Egli si scontrò così e vinse l'armata di Giacomo,
che non aveva nemmeno più voglia di combattere, a Solvay Moss.
Dal suo ritiro a Falkland, il triste re Giacomo aveva udito la notizia che l'erede che da tempo aspettava, non sarebbe nato: sua moglie gli avrebbe partorito una figlia. Dopo la sua susseguente morte, la giovinetta fu proclamata Regina di Scozia. Così, nel 1542, Maria, regina degli Scozzesi, entrò nel mondo in pressoché le stesse circostanze in cui l'avrebbe lasciato 45 anni più tardi. Dopo la morte di Giacomo, la madre di Maria, Marie de Guise, era determinata a governare con pugno di ferro, ma le sue attività intese a distruggere le attività dei protestanti in Scozia, riuscirono solo a promuovere ulteriori attività inglesi nel paese. Marie fallì, sebbene un'armata inglese non fosse riuscita a soccorrere una guarnigione protestante asserragliata a St. Andrew. Essa però schiacciò l'esercito reale scozzese a Pinkie, vicino ad Edimburgo. Ulteriori ostilità terminarono nel 1549 con il Trattato di Boulogne fra l'Inghilterra e la Francia, il che realizzò pure il ritiro delle truppe inglesi dalla Scozia.
 Ultimi
matrimoni. In quell'anno, Enrico VIII era morto già da
due anni. Jane Seymour era morta poco dopo aver dato alla luce Edoardo,
ed Enrico si era risposato già tre volte.
Ultimi
matrimoni. In quell'anno, Enrico VIII era morto già da
due anni. Jane Seymour era morta poco dopo aver dato alla luce Edoardo,
ed Enrico si era risposato già tre volte.
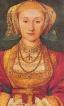 Thomas
Cromwell poi scelse Anne di Cleves come sposa di Enrico.
L'idea era quella di assicurarsi l'appoggio dei principi della Germania
del Nord contro il Sacro Romano Impero. Fu una cattiva scelta per il Lord
Cancelliere e il re, a cui non piaceva quella donna e la disprezzava chiamandola
“la giumenta delle Fiandre”. Il matrimonio non fu mai consumato,
e fu presto annullato dal Parlamento e l'alleanza con la Germania fallì.
Il volubile Enrico permise all'amareggiato rivale del Cromwell, il duca
di Norfolk, di portare accuse di tradimento contro di lui, e Cromwell
fu fatto decapitare senza processo nel 1540.
Thomas
Cromwell poi scelse Anne di Cleves come sposa di Enrico.
L'idea era quella di assicurarsi l'appoggio dei principi della Germania
del Nord contro il Sacro Romano Impero. Fu una cattiva scelta per il Lord
Cancelliere e il re, a cui non piaceva quella donna e la disprezzava chiamandola
“la giumenta delle Fiandre”. Il matrimonio non fu mai consumato,
e fu presto annullato dal Parlamento e l'alleanza con la Germania fallì.
Il volubile Enrico permise all'amareggiato rivale del Cromwell, il duca
di Norfolk, di portare accuse di tradimento contro di lui, e Cromwell
fu fatto decapitare senza processo nel 1540.
Nell'ultimo
periodo del proprio regno Enrico VIII fa approvare i “VI Articoli”
o Bloody Act (1539), che rimettevano in vigore il celibato dei preti,
la confessione auricolare, le messe private, la transustanziazione, la
comunione sotto una sola specie per i laici. Le persecuzioni contro i
luterani ripresero e venne raccomandata la devozione della Madonna e dei
santi e la revisione del Bishop's Book, mentre fu proibita la lettura
privata della Bibbia (1546). Prima con il duca di Somerset, che estese
la riforma di tipo luterano-melantoniano sequestrando beni ecclesiastici,
ordinando l'assunzione della santa Cena sotto le due specie e abolendo
i cosidetti “Sei Articoli”, e poi con il calvinista Eduardo
VI (1547-1553 figlio legittimo di Enrico VIII, nato dal terzo matrimonio
con Jane Seymour) la chiesa anglicana si dà un assetto protestante.
La Riforma, però, anche al tempo di Enrico VIII era saldamente
stabilita in Inghilterra, ed il potere della Chiesa cattolica definitivamente
spezzato.Il
re Enrico, vecchio, obeso ed afflitto dalla  gotta,
aveva poi sposato Caterina Howard (nipote del Duca di
Norfolk, primo ministro del re, luglio 1540-febbraio 1542), che sarebbe
presto stata decapitata per adulterio, e
gotta,
aveva poi sposato Caterina Howard (nipote del Duca di
Norfolk, primo ministro del re, luglio 1540-febbraio 1542), che sarebbe
presto stata decapitata per adulterio, e  Caterina
Parr (luglio 1542-gennaio 1547), l'ultima sua moglie, che gli
sopravvisse, ma che gli fu più infermiera che moglie).
Caterina
Parr (luglio 1542-gennaio 1547), l'ultima sua moglie, che gli
sopravvisse, ma che gli fu più infermiera che moglie).
Enrico VIII e la religione (1530-1547)
Enrico VIII è spesso ricordato come il monarca inglese che rompe con la Chiesa cattolica-romana. Enrico, però, era attratto dalle idee del Protestantesimo solo in maniera limitata, come dimostrano gli anni 1530-47.
Fra gli anni 1530-34 Enrico cerca di assicurarsi l'autorizzazione del Papa per divorziare da Caterina d'Aragona, minacciando dapprima il clero inglese e poi il potere del Papa in Inghilterra. Quando però il Papa non concede il divorzio, Enrico intraprende la più estrema delle misure, pretendendo egli stesso giurisdizione sulla Chiesa inglese. L'Atto di Supremazia regale del 1534 affermava che la Corona reclamava quei poteri che aveva sempre posseduto, poteri che Roma aveva usurpato durante i precedenti 400 anni – fatto che Enrico e i suoi consiglieri credevano fermamente.
Eppure, alla fine del 1534, la Chiesa inglese era ancora cattolica. Sebbene libera da Roma, le sue dottrine religiose non erano cambiate. Vi era, è vero, molto dibattito sulla forma che la dottrina della Chiesa avrebbe dovuto avere, ed Enrico incorporò alcune idee evangeliche nella sua chiesa. La dissoluzione dei monasteri, per esempio, era stata voluta prevalentemente sulla base di interessi finanziari e terrieri, ma spazzò via pure una grande e privilegiata società clericale. Questo era un attacco molto visibile alla Chiesa pre-riforma, e l'intero compito fu completato nei quattro anni che vanno dal 1536 al 1540.
Nel 1536, furono prodotti i Dieci Articoli come formulario della fede della nuova Chiesa. Questi articoli facevano riferimento a soli tre sacramenti – battesimo, penitenza ed eucaristia. Si trattava, in quel tempo, di una mossa radicale, ma anche fonte di confusione, e vi era molto dibattito al riguardo dei sacramenti “mancanti” della confermazione, ordine, matrimonio e estrema unzione. Un mese più tardi, le Ingiunzioni di Thomas Cromwell assunsero una posizione moderata contro le immagini nelle chiese e contro i pellegrinaggi. Furono pure banditi alcune feste sacre e giorni in onore di santi. La questione della transubstanziazione non era menzionata specificatamente, ed il concetto luterano di giustificazione per grazia mediante la fede, ne risultò molto annacquato. La religione ufficiale in Inghilterra, quindi, non condannava la Messa e nemmeno l'accento cattolico sulla necessità delle opere buone, ma si evidenziavano le parole della Scrittura ed i meriti della vita semplice dei cristiani. Era un tentativo di muoverso in una direzione evangelica.
Nel 1536, la “Istituzione di un uomo cristiano” è un ulteriore esempio di redigere un formulario della fede. Cerca di trattare della questione del purgatorio e lo statuto dei quattro sacramenti mancanti nei Dieci Articoli – che ora sono considerati sacramenti minori. Evidenziavano il fatto che la giustificazione mediante i meriti di Cristo, non dispensava dalle buone opere. Sulla questione della transustanziazione, il Libro del Vescovo dice chiaramente che: “Sotto la forma e figura del pane e del vino, che noi vediamo concretamente e percepiamo con i sensi esteriori, è veramente, sostanzialmente e realmente contenuto lo stesso corpo e sangue del nostro Salvatore Gesù Cristo”.
In ogni caso, un forte scossone all'impalcatura cattolica-romana fu dato nel 1537, quando fu accordato il permesso regale di avere una Bibbia nella lingua del popolo. Nel 1538 Cromwell emette nuove Ingiunzioni che stabilirono che ogni chiesa dovesse avere una copia della Bibbia inglese. La posizione centrale che le Sacre Scritture assumono nella fede protestante, rese vitale che il testo biblico fosse disponibile, ed una loro versione ufficiale diede il sigillo di approvazione della Bibbia inglese. Le Ingiunzioni del Cromwell pure assunsero una linea rigida contro l'uso delle immagini e dei centri di pellegrinaggio.
Questi tre anni, dal 1536 al 1538 segnarono il punto più alto della dottrina evangelica ufficialmente sanzionata sotto Enrico VIII. Il re era un abile teologo ed era disposto ad incorporare le idee evangeliche nella sua nuova chiesa dove riteneva meglio. Non era, però, molto a suo agio con i cambiamenti introdotti, e dal 1539 in poi, egli tornò indietro su molti punti della sua politica precedente. Nel 1539, l'Atto dei Sei Articoli fecero ritornare la Chiesa ad un'ortodossia cattolica non ambigua, ad eccezione della supremazia papale. Fra le altre cose, furono riaffermate la transustanziazione e la confessione auricolare. Il matrimonio dei preti, che era stato introdotto di soppiatto, fu condannato, ed i voti di castità furono ritenuti inviolabili. Questo fu d'imbarazzo all'Arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, il cui stesso matrimonio era un segreto ormai pubblico.
In modo ancor più significativo, in questo Atto, l'eresia divenne legalmente un crimine. Questo era un chiaro segnale che Enrico VIII non avrebbe tollerato idee religiose radicali. Enrico cercò di stabilire un accordo fra Protestanti e conservatori. I Protestanti erano puniti se violavano i Sei Articoli, mentre i Papisti erano puniti se negavano la supremazia papale.
Fino alla
morte di Enrico VIII nel 1547, gli Atti dei Sei Articoli rimasero la base
della fede della Chiesa. Nel 1543, “Una Necessaria Dottrina ed Erudizione
per un Qualsiasi Uomo cristiano” prendeva le parti di un'ortodossia
tradizionale, e sostituivano semplicemente la supremazia papale con l'autorità
del re. Qualsiasi traccia di Luteranesimo che era presente nel libro “Istituzione
di un uomo cristiano”, era ora scomparsa. Sebbene la Bibbia inglese
fu conservata, il suo accesso fu severamente limitato dall'Atto per la
Promozione della Vera Religione nel 1543. Esso permetteva di leggere la
Bibbia solo a uomini e donne di classe superiore. Le donne potevano leggerla
solo in privato.
Enrico VIII si era solo un poco baloccato con le idee protestanti, ma
alla fine si era comprovato conservatore in questioni di dottrina religiosa.
Sarebbe stato necessario suo figlio, Edoardo VI, ed i suoi consiglieri,
a portare l'Inghilterra in qualcosa che avesse potuto essere definito
una vera nazione protestante.