|
Sozzini (o
Socini, Sozini, Sozzino, Socino o Socinus), Fausto Paolo (1539-1604) e
Socinianesimo in Polonia
http://www.eresie.it/id635.htm
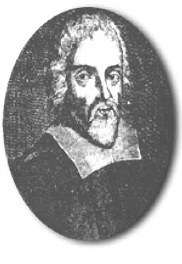 I primi anni I primi anni
Il famoso teologo
antitrinitario Fausto Paolo Sozzini (o Socini: per le
altre varianti del cognome, vedere il titolo), nome umanistico Faustus
Socinus, nacque il 5 dicembre 1539 a Siena, primogenito del giurista
Alessandro Sozzini (1509-1541) [a sua volta primogenito del giureconsulto
Mariano Sozzini il giovane (1482-1556)] e di Agnese Petrucci, discendente
di Pandolfo Petrucci (1452-1512), governatore di Siena dal 1487 al 1512.
Il piccolo Fausto,
dopo la nascita della sorella Fillide (1540-1568), rimase nel 1541 orfano
del padre, e dopo poco anche della madre. Egli fu allevato nella famiglia
paterna senza un'educazione regolare, con un interesse più per le lettere
che per la giurisprudenza (gli studi tradizionali della famiglia Sozzini),
sotto lo stimolo culturale di suo zio Celso, professore di diritto a
Bologna, e proprio in questa città Celso trasportò nel 1554 l'Accademia
senese dei Sizienti, di cui S., pare, abbia fatto parte.
E' sicuro invece la
sua adesione, nel 1557, all'Accademia senese degli Intronati, dove egli
entrò con il nome di Frastagliato, sempre al seguito dello zio Celso, che
aveva assunto il nome di Sonnacchioso. Le riunioni degli Intronati, votati
alle discussioni sulla letteratura, lingua e religione furono per S.
senz'altro più interessanti di quelle dei Sizienti, dedicati solo ad
argomenti giuridici. Comunque, per sua fortuna, non dovette affidarsi ad
un titolo di studi per vivere, perché, nel 1556, alla morte del nonno
Mariano, S. poté disporre (per più di trent'anni) di una certa sicurezza
economica, quando ricevette in eredità un quarto dei beni di famiglia.
Lo sviluppo del
pensiero religioso di S.
I primi interessi
religiosi eterodossi di S. gli furono trasmessi dallo zio
Lelio, che, benché esule dal 1547 in Svizzera per motivi
religiosi, ebbe la possibilità di rivisitare Siena e parlare col nipote
nel 1552.
Nel 1558 S. fu
coinvolto nel processo per eresia a carico degli zii Celso e Camillo,
segno di un graduale schieramento a favore delle scelte protestanti dei
famigliari. Nel 1561 egli lasciò Siena per recarsi a Lione ufficialmente
per impratichirsi nell'arte mercantile, ma nella città francese egli spese
due anni della sua vita soprattutto ad approfondire le sue conoscenze
religiose e a mantenere i contatti con lo zio Lelio, che abitava a Zurigo.
Avvertito della morte di quest'ultimo, avvenuto il 14 maggio 1562, da
parte del mercante Antonio Mario Besozzi (m. 1567), S. accorse a Zurigo
per raccogliere gli scritti di Lelio, che poi usò per meditare e
sviluppare la dottrina del pensiero sociniano: già nell'aprile 1563,
rielaborando concetti di Lelio, S. aveva composto un commento all'incipit
del Vangelo di San Giovanni, dal titolo Explicatio primae partis primi
capiti Evangelii Johannis, dove però, rispetto allo zio, S. diede più
forza al carattere spirituale di Cristo.
In seguito S. si
stabilì per un breve periodo a Basilea (sebbene il suo nome fosse anche
citato nell'elenco degli iscritti alla Chiesa degli Italiani a Ginevra),
dove conobbe
Celio Secondo Curione, amico dello zio Lelio. S. si recò
anche a Zurigo, dove fu tuttavia coinvolto nell'espulsione, per le sue
idee antitrinitarie, antiecclesiastiche e contro i Sacramenti, di
Bernardino Ochino (da S. conosciuto nella città svizzera)
da parte del riformatore
Johann Heinrich Bullinger nel dicembre 1563.
A questo punto S.,
nonostante fosse già abbastanza compromesso con la Riforma, prese la
sconcertante decisione di ritornare in Toscana. Sulla strada di ritorno,
passò per Chiavenna, dove fece visita all'amico e maestro
Ludovico Castelvetro.
Il periodo
fiorentino (1563-1574)
Effettivamente non è
del tutto chiaro perché S. decidesse di rientrare in Italia, visto che poi,
per la sua stessa incolumità, dovette poi osservare una prassi fortemente
nicodemitica: infatti per i successivi 11 anni (dal 1563 al 1574) si tenne
per sé le sue intime elucubrazioni religiose.
S. si trasferì a
Firenze ed entrò come segretario al servizio di Isabella de'
Medici(1542-1576), figlia del granduca Cosimo I de' Medici (duca di
Firenze: 1537-1569 e granduca di Toscana: 1569-1574), e del marito Paolo
Giordano Orsini (1537-1585), accompagnando la sua protettrice a Roma nel
1571 e componendo poemi e sonetti, di cui i più ispirati furono quelli
composto in onore della sorella Fillide, morta nel 1568 e di Ludovico
Castelvetro, morto il 21 febbraio 1571, in cui S. dichiarò che il modenese
gli aveva chiaramente mostrato la via da seguire: l'esilio (in terra
protestante) e la palese professione di fede.
Nel frattempo (1568)
fu stampato, sotto lo pseudonimo del gesuita Domenico Lopez, il suo
scritto teologico De Sacrae Scripturae Autoritate, che, applicando
i metodi della filologia moderna, introdotti da
Lorenzo Valla, ribadiva l'autorità della Sacra Scrittura
e l'eccellenza della religione cristiana. L'uso di uno pseudonimo fu
probabilmente frutto di un accordo segreto con Cosimo I: il granduca
avrebbe accordato la sua protezione, a patto che S. non pubblicasse i suoi
scritti con il proprio nome. L'accordo proseguì anche con il successore di
Cosimo, Francesco Maria (1574-1587) e garantì il regolare afflusso di
proventi verso il paese estero, dove S. aveva, in volta in volta,
stabilito la propria residenza.
Nonostante la
dichiarazione in occasione della morte di Castelvetro e la pubblicazione
del De Sacrae Scripturae Autoritate, S. prese la decisione di
abbandonare per sempre l'Italia solo dopo la morte del Granduca Cosimo I
de' Medici, avvenuta nell'aprile 1574. Del resto, due anni dopo, nel
giugno 1576, avvenne una tragedia che avrebbe rinforzato la sua decisione:
la sua protettrice, Isabella de' Medici, fu strangolata dal gelosissimo
marito, che aveva saputo dell'esistenza di un amante della moglie [sebbene
avesse lui stesso come amante Vittoria Colonna Accoramboni (1557-1585)].
Quindi nulla poté il nuovo granduca, Francesco Maria, fratello di
Isabella, per convincere il senese a recedere dalla sua decisione. Tra
l'altro, la scelta di S. era dettata dalla necessità di vivere in un
ambiente, che gli permettesse di sviluppare con serenità e sicurezza i
suoi studi sulle Scritture.
S. in Svizzera
Nella seconda metà del
1574, quindi, S. emigrò in Svizzera, a Basilea, dove i capi religiosi
erano i tolleranti riformatori Theodore Zwinger (1533-1588) e Basilio
Amerbach (1533-1591): per quest'ultimo lo zio Lelio aveva scritto una
lettera di presentazione nel lontano 1547, quando lo svizzero aveva
espresso il desiderio di recarsi in Italia per completare i suoi studi di
giurisprudenza. A Basilea S. risedette per circa quattro anni, studiando
le Sacre Scritture e soprattutto il problema della redenzione, sul quale
argomento scrisse due trattati: la sua opera principale De Jesu Christo
Servatore (Gesù Cristo salvatore), finita nel 1578, pubblicata
parzialmente (ma senza il suo consenso) nel 1583 e interamente in Cracovia
nel 1594, e il trattato De statu primi hominis ante lapsum (Sulla
condizione del primo uomo prima della Caduta), sempre scritta nel 1578, ma
pubblicata postuma nel 1610.
Il primo trattato,
nato dalle discussioni con i riformatori Gerolamo Marliano, Giovanni
Battista Rota (pastore della Chiesa italiana a Ginevra),
Manfredi Balbani e Jacques Couët du Vivier (1547-1608),
esponeva l'idea di S. a riguardo della redenzione: il punto principale
della dottrina protestante della giustificazione per fede non era il
sacrificio di Cristo compiuto per espiare i nostri peccati, bensì la
rivelazione divina attraverso l'esempio della vita di Cristo, vero
salvatore e redentore degli uomini.
Il secondo trattato,
invece, si inserì nella polemica in atto tra S. e
Francesco Pucci, il pensatore utopistico che rigettava
il concetto di peccato originale: secondo Pucci, l'uomo è immortale e si
danna solo quando, razionalmente, devia dalla legge divina. Per S., che si
confrontò con Pucci nel 1577 a Basilea in un incontro organizzato da
Francesco Betti, l'uomo, essere mortale, si deve invece
conquistare l'immortalità con la fede attiva.
S. in Transilvania
Una copia del
manoscritto del De Jesu Christo Servatore giunse fino in
Transilvania e attirò l'attenzione del riformatore antitrinitario e medico
Giorgio Biandrata, che invitò S. a recarsi a Kolozsvàr (oggi
Cluj in Romania) nel novembre 1578, per polemizzare con
Ferenc Dàvid, il quale aveva aderito alla fazione degli
antitrinitariani non-adoranti, coloro i quali negavano il ruolo di guida
per i fedeli verso la salvezza del Cristo e rifiutavano, conseguentemente,
ogni forma di adorazione di Gesù Cristo. A loro si contrapponevano gli
antitrinitariani adoranti, che ponevano la figura di Cristo come
riferimento per la salvezza degli uomini. Da qui si comprende l'interesse
di Biandrata verso il trattato di S., che considerava Gesù Cristo colui il
cui compito era di rivelare Dio agli uomini, i quali potevano così
raggiungere la salvezza, seguendo il Suo esempio.
L'inattesa conclusione
della discussione avvenne nel giugno 1579, quando, su denuncia di
Biandrata, Dàvid fu fatto arrestare in giugno e imprigionare nella
fortezza di Déva dove morì il 15 novembre dello stesso anno.
S. in Polonia
S. non prese comunque
parte attiva alla tragedia umana di Dàvid, perché, già nel maggio 1579, si
era trasferito in Polonia, presso i Fratelli Polacchi, l'ecclesia minor
di fede antitrinitaria (o unitariana) che aveva mantenuto le
caratteristiche
ariane (in particolare il concetto che Cristo era
pre-esistito alla creazione del mondo e quindi era giusto adorarlo) e
anabattiste, datale da
Pietro Gonesio: fu soprattutto l'arrivo di S. che
contribuì ad uniformare la dottrina sui principi proposti dal senese.
S. pose la sua
residenza a Cracovia, sebbene il centro di riferimento per l'unitarismo
polacco fosse la vicina cittadina di Raków, dove era stato fondato un
seminario di studi antitrinitari nel 1569 e dove, tra il 1603 ed il 1605,
sarebbe stato redatto il catechismo ufficiale della setta. Curiosamente S.
non fece ufficialmente parte della Chiesa antitrinitariana di Cracovia, se
non in tarda età, a causa del suo rifiuto di farsi ribattezzare (l'influenza
anabattista era ancora molto forte sugli antitrinitariani polacchi) da
parte del pastore Szymon Ronemberg.
Qui, però, riprese la
polemica tra adoranti ed alcuni esponenti non-adoranti, come
Giacomo Paleologo, Jànos Sommer (1540-1574), e
Andrea Dudith Sbardellati: comunque, oltre alla solita
diatriba se fosse giusto o meno adorare Gesù Cristo, con il suo De Jesu
Christi filii Dei natura sive essentia, S. attaccò i non-adoranti come
giudaizzanti, che volevano, tra l'altro, santificare il sabato, secondo un
uso
sabbatariano, che si sarebbe espanso in Inghilterra,
portatovi proprio dagli antitrinitariani profughi dalla Polonia.
Inoltre un altro punto
di frizione con S. fu l'obbligo morale, secondo Paleologo, del cristiano
nella difesa, anche prendendo le armi, del paese che offriva la sua
ospitalità. S. era in totale disaccordo con questa tesi: per
l'antitrinitariano senese, il cristiano, secondo l'interpretazione del
Nuovo Testamento, non poteva versare il sangue di altri cristiani.
I toni della polemica
furono così accesi che il medico
Marcello Squarcialupi, amico di Biandrata, nel 1581
scrisse una lettera a S. per richiamarlo ad abbassare i toni della
polemica, che danneggiava l'immagine degli esuli italiani.
Comunque, a parte
questo episodio, S. mantenne sempre buone relazioni sociali con diversi
esuli italiani in Polonia, soprattutto con
Niccolò Buccella, che diventò suo amico fraterno e che
nominò S. come uno dei suoi eredi, e con
Prospero Provana, che lo ospitò spesso in sua casa.
Nel marzo 1583,
temendo rappresaglie da parte del fronte cattolico polacco, S. decise di
andare ad abitare nel villaggio di Pawlikowice (oggigiorno Roznów, sudest
di Cracovia), ospite del nobile polacco Krzysztof Morsztyn, e ne sposò la
figlia Elizabeth nel 1586. L'anno dopo nacque l'unica figlia di S., Agnese
(1587-1654), ma, nello stesso anno morì la moglie. Il 1587 fu anche l'anno
della morte del suo protettore in patria, Francesco Maria de' Medici, e,
nonostante S. mantenesse apparentemente dei buoni rapporti con il nuovo
granduca, Ferdinando I (1587-1609), l'Inquisizione a Siena gli sequestrò i
beni, con l'accusa di eresia. Tuttavia la perdita di introiti dalla
madrepatria fu parzialmente compensata dalla possibilità di pubblicare con
il proprio nome le sue opere, poiché, come si è detto precedentemente,
l'anonimato era la conditio sine qua non imposta prima da Cosimo I,
poi da Francesco Maria de' Medici perché S. potesse continuare a ricevere
i proventi delle sue proprietà di famiglia.
Nel 1588 S. riuscì
nell'impresa di unire tutte le fazioni antitrinitariane al sinodo di Brest
(Brzesc, in Lituania) e, in suo onore, da questo momento gli
antitrinitariani si denomineranno sociniani. Oltretutto la crescente
popolarità presso la nobiltà polacca e l'autorevolezza dei suoi interventi
fecero sì che nel 1596 S. fosse nominato capo della Chiesa sociniana
polacca.
Tuttavia la
conseguenza fu che egli dovette fronteggiare una violenta reazione, anche
di piazza, dei cattolici: nel 1591 il suo punto d'incontro a Cracovia fu
devastato dalla folla, ma soprattutto, nel 1598, gli studenti universitari,
sobillati dai gesuiti, fecero irruzione nella sua casa di Cracovia, mentre
giaceva a letto ammalato: S. stesso fu malmenato e portato davanti al
municipio, dove vennero bruciati i suoi scritti e i suoi libri. Richiesto
di abiurare, rifiutò e fu quindi trascinato via per essere annegato nel
fiume Vistola, e solo il tempestivo intervento di un professore
universitario, Martin Wadowit, gli salvò la vita.
Temendo quindi per
altri attacchi di fanatici, S. si trasferì da Cracovia a Luslawice, un
villaggio a nord di Tarnów, a 30 km. da Cracovia, ospite di Abraham
Blonski, e qui iniziò, senza poterla finire, la stesura della bozza di un
catechismo antitrinitariano, la Christianae religionis brevissima
institutio, per interrogationes et responsiones, quam catechismus vulgo
vocant, che fu la base del catechismo ufficiale, redatto, dopo la sua
morte, dal fedele discepolo Piotr Stoinski junior (m. 1605), assieme a
Valentinus Smalcius (1572-1622), Hieronymus Moskorzowski (m. 1625) ed
altri, in polacco nel 1605.
Il testo fu poi
tradotto in tedesco nel 1608, in latino nel 1609, ed in inglese, a cura di
John Biddle, nel 1652 con il titolo di The Racovian
Catechisme (Catechismo di Raków), nome con il quale oggi è conosciuto
nel mondo anglosassone unitariano.
S., ormai vecchio e
sofferente per ripetute coliche e calcoli renali, morì a Luslawice il 4
marzo 1604. Dapprima sulla sua tomba fu posta la scritta Chi semina
virtù, raccoglie la fama, e vera fama supera la morte, ma nel 1936 i
suoi resti furono posti in un mausoleo, dove sulla sua tomba vennero
scritte queste significative parole: Crolli la superba Babilonia:
Lutero ne distrusse i tetti, Calvino le mura, Socini le fondamenta.
Il pensiero religioso
Secondo Marian Hillar,
il nocciolo delle dottrine sociniane si riassumano in dieci punti:
Il pensiero di S.,
fortemente razionale, accettava un solo Dio, mentre Gesù Cristo era
semplicemente un uomo crocefisso, il cui compito era di rivelare Dio agli
uomini, permettendo loro di raggiungere così la salvezza, seguendo il Suo
esempio. Per lui la Sacra Scrittura, redatta da uomini, non era indenne da
errori, e l'uomo doveva basarsi sulla propria etica per osservare i
comandamenti e non era quindi necessaria la grazia divina. Egli, inoltre,
negava l'esistenza dell'inferno, il peccato originale, la necessità dei
sacramenti, la predestinazione, e, rispetto ai Fratelli Polacchi,
rifiutava il secondo battesimo.
La fine del socinianesimo in Polonia
Pochi anni dopo, nel
1610, sotto il regno di Sigismondo Augusto III (1587-1632), la potente
organizzazione gesuita sbarcò in Polonia decretando il rapido declino
degli antitrinitariani (o unitariani) in Polonia: il 6 novembre 1611 fu
bruciato sul rogo a Varsavia l'unitariano Jan Tyskiewicz, un agiato
cittadino di Bielsk, per essersi rifiutato di giurare sulla Trinità e nel
1638 fu chiuso il seminario di Raków.
Il colpo finale per
l'unitarismo in Polonia fu comunque, durante il regno di Giovanni Casimiro
(1648-1668), il bando di espulsione per tutti gli unitariani polacchi,
deciso nel 1658 e diventato esecutivo il 10 luglio 1660, che li costrinse
o ad uniformarsi al cattolicesimo o ad emigrare in altri paesi europei (in
Olanda, dove la maggior parte si trasferì aderendo alla
Chiesa Arminiana dei rimostranti, in Germania, e in
Transilvania, dove però essi non aderirono alla Chiesa Unitariana
Transilvana, ma formarono una chiesa autonoma a Kolozsvàr estinguendosi
nel 1793). Nel 1668 fu introdotta la legge, che prevedeva la pena di morte
per i cattolici battezzati, che si fossero convertiti al protestantesimo.
L'ultima sacca di
resistenza unitariana in Polonia si estinse nel 1811 e solo nel 1921
furono riaccettate le congregazioni unitariane nella nazione rinata dopo
secoli di dominazione straniera. Ma la successiva occupazione nazista nel
1939 e l'instaurazione del comunismo ha fatto sì che l'unitarianismo
polacco potesse incominciare a muovere nuovamente qualche timido passo
solamente dopo la caduta del muro di Berlino, negli anni '90 del XX secolo.
L'attuale Chiesa unitariana in Polonia comprende solo qualche centinaio di
fedeli.
Per lo sviluppo del
socinianesimo in altri paesi, vedi
unitarianismo.
|