Giovanni (John) Florio
seguito di: Michelangelo e Giovanni
Florio ed il loro contributo alla lingua, cultura e letteratura inglese
 Arrivato in
Inghilterra nel 1575, dopo aver ricevuto istruzione universitaria a Tubinga,
diventa insegnante di lingue straniere a Londra, vicino allo Strand
(abitazioni in Upper Thames Street, chiamate Worcester Place). Dedica una
sua opera al conte di Leicester, il cui padre, il Duca di Northumberland,
aveva conosciuto suo padre ed era appassionato alla cultura italiana.
Difatti, Michelangelo aveva dedicato il suo catechismo al Duca. Il padre di
Giovanni, con i suoi numerosi contatti con l’aristocrazia, aveva così
preparato in Inghilterra il terreno al figlio. Arrivato in
Inghilterra nel 1575, dopo aver ricevuto istruzione universitaria a Tubinga,
diventa insegnante di lingue straniere a Londra, vicino allo Strand
(abitazioni in Upper Thames Street, chiamate Worcester Place). Dedica una
sua opera al conte di Leicester, il cui padre, il Duca di Northumberland,
aveva conosciuto suo padre ed era appassionato alla cultura italiana.
Difatti, Michelangelo aveva dedicato il suo catechismo al Duca. Il padre di
Giovanni, con i suoi numerosi contatti con l’aristocrazia, aveva così
preparato in Inghilterra il terreno al figlio.
Nel 1576 John Florio vive ad Oxford e svolge la funzione di tutore del
figlio del vescovo di Durham.
Giovanni si fa conoscere come un uomo molto colto ed interessante. Parla
chiaramente inglese senza accento straniero (aveva solo due anni quando
lasciò Londra).
Nel 1578 scrive il suo primo libro (First Fruits) in inglese sui proverbi
italiani. In esso parla di come i genitori dovrebbero insegnare ai loro
figli molte lingue. Si lamenta del fatto che gli inglesi non sappiano
parlare altre lingue. Le raccolte di dialoghi First Fruits (1578) e Second
Fruits (1591) furono certo conosciute da Shakespeare che ne riporta diversi.
La sua prima opera manifesta autentici sentimenti religiosi puritani. Yates
suggerisce che questo fosse un segno della tendenza “sociniana” del padre
che, in quei tempi, si mascherava come estremo puritanismo. Yates parla del
“First Fruits” come un manuale di morale, con idee in parte derivanti da
Guevara e Guicciardini. Florio, così,
si afferma ben presto nei circoli intellettuali di Sidney-Leicester.
Florio valuta molto la castità cristiana – rilevandone i vantaggi: fama,
sapienza, continenza, salute e rispetto. In questo, forse, si vuole
distanziare dagli errori del padre a Londra.
 Nel 1581 si iscrive al Magdalen College insieme al poeta ed intellettuale
Samuel Daniel. Frequenta questo college, di
tendenza puritana, con una borsa di studio. Ancora oggi, in questo college,
è attiva una Florio Society. Nel 1581 si iscrive al Magdalen College insieme al poeta ed intellettuale
Samuel Daniel. Frequenta questo college, di
tendenza puritana, con una borsa di studio. Ancora oggi, in questo college,
è attiva una Florio Society.
Si pensa che sposò la sorella del Daniel. Ha una figlia, Joanna, battezzata
ad Oxford e vice vicino al Worcester College. Insegna lingue europee ad
Oxford, in particolare l’italiano. Conosce
Philip Sidney, Conte di Leicester, e
Walsingham, capo del servizio segreto inglese.
Nel 1580 traduce per Edward Bray, sceriffo di Oxford, il “Ramusio”.
Nel 1582 scrive un altro libro sui proverbi italiani, e lo dedica all’amico
Philip Sidney, come pure scrive un’operetta per Sir Edward Dyer.
Dal 1582 in poi è traduttore per l’ambasciata francese di Londra e, con la
sua famiglia, vive nella Shoe Lane di Londra. Insegna italiano ed altre
lingue alla brillante figlia dell’ambasciatore francese
Michel de Nauvissière , sin dall’età
di quattro anni. Accompagnava l’ambasciatore nelle udienze con la regina
Elisabetta.
In questa ambasciata Florio viveva accanto al filosofo italiano Giordano
Bruno , poi martire a Roma delle sue idee. L’amicizia con
Giordano Bruno lo influenza nell’includere
nel suo dizionario italiano-inglese, anche termini napoletani. In una copia
di un libro del Bruno a Napoli, sono stati trovati manoscritti che
descrivono una serata passata a Londra con il Florio. Pare che in questa
serata essi dovessero incontrare Sir Philip Sidney, Sir Fulke Greville (da
loro chiamato “Fulko”) e con due professori di Oxford. Bruno non parlava
inglese, così si avvaleva della traduzione del Florio. In questo incontro,
incentrato sulla fantascienza (!) Bruno sosteneva che l’antica concezione
greca dell’universo fosse errata e che la terra non è che uno fra tanti
mondi, e che gli altri pianeti dovessero essere pure abitati. Immaginava un
universo infinito. Pare che Sidney e Greville fossero molto interessati a
queste idee. Florio evidentemente conosceva il protestante Sidney (lo
“spirito angelico” degli elisabettiani, che tradusse i Salmi in versi
inglesi). Florio, così conosceva ed incontrava Walsingham,
Raleigh, Sidney, Spencer (dal quale pare abbia
“rubato” la moglie Rosa, o Rosaline), come pure il poeta Samuel Daniel (che
pure probabilmente agiva come spia a Parigi.
Nel 1583 egli, sorprendentemente, viene reclutato fra le spie del Walsingham
al servizio segreto inglese, e mette a rischio la sua vita nell’ambasciata
francese, intercettando messaggi di Maria, regina di Scozia, ai cattolici
francesi. Pare che anche il poeta Christopher Marlowe
servisse, allo stesso modo, come spia inglese.
 Florio sembra così diventare a Londra una “pietra di paragone”
intellettuale. Insegna stilistica letteraria ed introduce l’uso dei proverbi
scrivendo, appunto, un libro di proverbi, alcuni dei quali appaiono nelle
opere del Shakespeare. Florio sembra essere determinante nell’affermazione
del famoso stile “eufuistico” pre-shakespeariano che, di fatto, è il primo
stile altamente drammatico del teatro elisabettiano.
Lyly, autore del “Euphues” (il drammaturgo) era suo allievo e così era
l’amico più intimo del Sidney (della stessa città di Shakespeare),
Sir Fulke Greville . Florio sembra così diventare a Londra una “pietra di paragone”
intellettuale. Insegna stilistica letteraria ed introduce l’uso dei proverbi
scrivendo, appunto, un libro di proverbi, alcuni dei quali appaiono nelle
opere del Shakespeare. Florio sembra essere determinante nell’affermazione
del famoso stile “eufuistico” pre-shakespeariano che, di fatto, è il primo
stile altamente drammatico del teatro elisabettiano.
Lyly, autore del “Euphues” (il drammaturgo) era suo allievo e così era
l’amico più intimo del Sidney (della stessa città di Shakespeare),
Sir Fulke Greville .
Sembra che Florio conoscesse un po’ tutti e che fosse pure ben accolto in
molti ambienti facendo una buona impressione. La vita pulita, istruzione,
talenti e carattere del Florio riescono così a ristabilire la reputazione a
Londra della loro famiglia, dopo che il padre Michelangelo era stato
licenziato dal suo ruolo di pastore nella comunità riformata italiana di
Londra.
Vi sono evidenze che Florio chiamasse sé stesso “L’Eliotropo” o “il
girasole”, dato che troviamo questo fiore nel suo stemma. Le descrizioni che
troviamo del suo carattere lo rappresentano come pedante ma cortese.
L’espressione “Love’s Labours Lost” è una frase che appare prima nelle sue
opere e poi nei sonetti del Shakespeare. Il suo stile letterario è
descrittivo, elegante e molto vivace.
Appare nel Calendario del pastore, di Edmund
Spenser come amante di Rosalinda e sotto lo pseudonimo di Melacas
(risoluto), un carattere seducente ed immorale. Melacas John Florio
(il risoluto John Florio) era il modo in cui lo stesso Florio sempre si
firmava in tutte le sue lettere. Florio definiva sé stesso pure come un
“italiano anglificato”, o meglio “angelificato” (giocando sulle parole).
Dal 1590 al 1598 è segretario del Barone di Southampton, patrono dello
Shakespeare e scrive un primo dizionario italiano-inglese “A Worlde of
Wordes” (1598), in seguito ampliato (1611).
Nel 1603 traduce liberamente in inglese i saggi di
Montaigne.
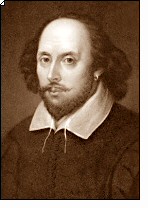 Diventa
insegnante di italiano per la regina Anna ed il principe di Galles.
Frequenta la corte inglese insieme a Shakespeare . Apparentemente è Florio
che insegna a Shakespeare l’italiano, tanto da
parlarlo poi fluentemente. Diventano molto probabilmente amici e sembra che
ci sia un riferimento al Florio nella sua poesia “Phaeton”. Descrive il suo
“dolce amico” Florio come “fiori” e “frutti” (in onore dell’opera di quest’ultimo
“First Fruits”, segni della primavera e dell’estate (che Shakespeare spesso
amava descrivere nei Sonetti. Essa parla di come l’Inghilterra fosse priva
di frutti della grazia e dello stile letterario, prima che Florio
intervenisse. Termina con i versi: “Such fruits, such flowers of morality
Were never before brought out of Italy” (Tali frutti, come i fiori della
moralità, non furono mai portati prima dall’Italia). Diventa
insegnante di italiano per la regina Anna ed il principe di Galles.
Frequenta la corte inglese insieme a Shakespeare . Apparentemente è Florio
che insegna a Shakespeare l’italiano, tanto da
parlarlo poi fluentemente. Diventano molto probabilmente amici e sembra che
ci sia un riferimento al Florio nella sua poesia “Phaeton”. Descrive il suo
“dolce amico” Florio come “fiori” e “frutti” (in onore dell’opera di quest’ultimo
“First Fruits”, segni della primavera e dell’estate (che Shakespeare spesso
amava descrivere nei Sonetti. Essa parla di come l’Inghilterra fosse priva
di frutti della grazia e dello stile letterario, prima che Florio
intervenisse. Termina con i versi: “Such fruits, such flowers of morality
Were never before brought out of Italy” (Tali frutti, come i fiori della
moralità, non furono mai portati prima dall’Italia).
Si sposa nel 1617 con Rose “Spider”, che ama teneramente. Il suo stesso
testamento è una lettera d’amore per lei. Diventa maggiormente religioso in
età avanzata.
Obiettivo del Florio era dare alla lingua inglese eleganza e raffinatezza,
forti ambizioni linguistiche.
Dà il nome al Golfo di S. Lorenzo in Canada traducendolo erroneamente da un
libro del famoso navigatore Sir Richard Hakluyt .
Nella prefazione a questo libro Florio incoraggia la colonizzazione
dell’America – quasi prima di chiunque altro – per diffondere l’influenza
della lingua inglese, che egli amava.
Muore nel 1625 a Fullham. Lascia nel testamento innumerevoli libri al
conte di Pembroke ed dei gioielli dati alla
regina Anna dal Duca Ferdinando di Bologna, come gesto di riconoscenza per
la protezione ottenuta, come pure una pensione per la sua vedova, da William
Herbert , il “giovanotto” dei sonetti di Shakespeare. |
|